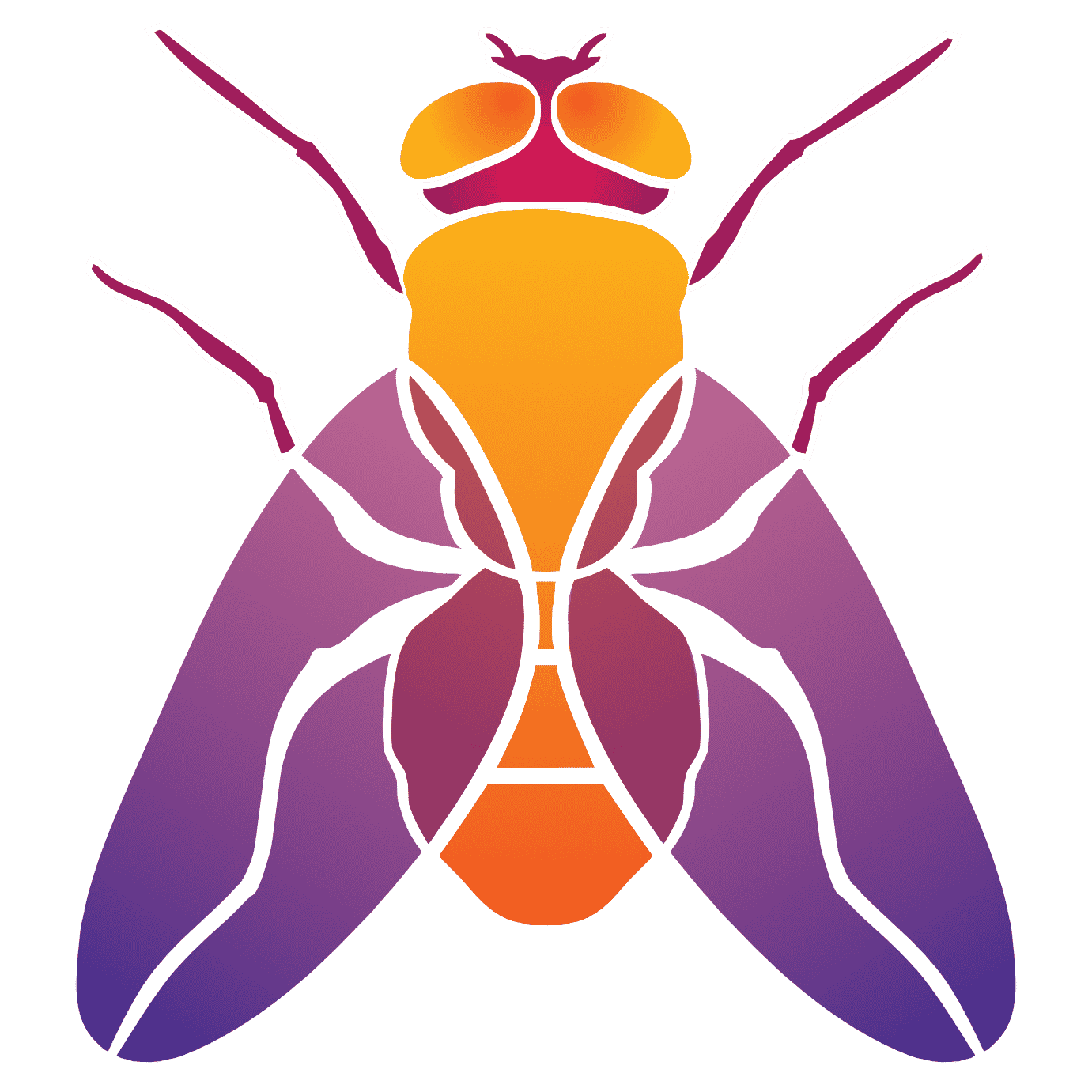“Làszlò Tòth è un famoso architetto ungherese, costretto a fuggire dal suo Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, per scappare dalle persecuzioni naziste in quanto ebreo, recandosi negli Stati Uniti. Qui vive di lavori umili e logoranti, finché l’incontro con un potente magnate non gli cambierà per sempre l’esistenza, nel bene e nel male…“

La carriera cinematografica del 36enne statunitense Brady Corbet è (senza alcuna esagerazione) un unicum nella storia della settima arte: debuttò come attore sin da adolescente (aveva appena 14 anni), segnalandosi in pochi (ma buoni) film come uno dei caratteristi più promettenti del cinema indipendente americano (da segnalare in particolare la sua performance in “Mysterious Skin” di Gregg Araki, 2004), lavorando poi con registi del calibro di Michael Haneke e Lars von Trier.
Nel 2014, però, decide sorprendentemente di smettere di stare davanti alla macchina da presa, per dedicarsi esclusivamente alla carriera dietro di essa, una scelta più unica che rara. Debutta come regista con “L’infanzia di un capo” (2015), proseguendo poi con “Vox Lux” (2018), due opere che già dimostravano ampiamente un innegabile talento e una sfrontata ambizione sia nella messa in scena che nella narrazione.
Nella sua terza opera, The Brutalist (2024), tutto viene portato alle estreme conseguenze, dalle scelte narrative (ben tre ore e mezza di durata…) a quelle stilistiche, raggiungendo una piena maturità autoriale che forse mancava ancora nei due film precedenti, ma che con quest’opera si realizza pienamente.
La lavorazione di The Brutalist è stata, come ogni grande opera che si rispetti, lunga e travagliata: dopo aver impiegato anni per farsi approvare il progetto ed ottenere i finanziamenti necessari, le riprese del film, previste per il 2020, vennero dapprima interrotte per via della pandemia di Covid, e successivamente, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, non fu possibile girare delle scene in Polonia per motivi di sicurezza, cosa che tardò ulteriormente la lavorazione. Dopo ben tre anni, nel marzo del 2023, le riprese iniziarono ufficialmente, nella zona di Budapest, per poi concludersi nel maggio dello stesso anno.
The Brutalist è un film indipendente travestito da kolossal, essendo costato “appena” 10 milioni di dollari: un budget stranamente esiguo per come ci si aspetterebbe da un’opera del genere, ma che però ha garantito al regista la possibilità di avere maggior libertà creativa, con poche interferenze da parte dei produttori.
Un’ altra particolarità è l’essere girato in VistaVision, primo film statunitense ad essere girato in questo formato dai tempi de “I due volti della vendetta” (“One Eyed Jakcs”, 1961), prima e unica regia di Marlon Brando: una scelta fatta sia per motivi filologici (essendo tale formato usato nei film ambientati negli anni 50, in cui si ambienta la vicenda dell’opera), sia perché secondo lo stesso regista il VistaVision è perfetto per un film sull’architettura, in quanto gli permetterebbe di “inquadrare un palazzo di sei piani da cima a fondo con un semplice obiettivo 50 mm, come con un volto umano“.
Diviso in 4 parti, comprendenti una breve introduzione (“Overture“), due lunghissimi atti che dipanano tutta la vicenda (“l’Enigma dell’arrivo” e “Il Nocciolo duro della bellezza“), e un’ altrettanto breve chiusura (“Epilogo“), inframezzati da un intervallo di 15 minuti, The Brutalist è l’epopea personale e universale dell’architetto ungherese, ed ebreo, László Tóth (un Adrien Brody in stato di grazia) che, dopo essere fuggito da un campo di concentramento nazista, si imbarca su una nave per gli Stati Uniti d’America, terra di sogni e speranze per eccellenza, in cui ricominciare una nuova vita, nell’attesa di ricongiungersi con moglie e figlia, rimaste in Ungheria.
Già nell’Overture che apre il film, scandito dall’ossessiva e ipnotica colonna sonora di Daniel Blumberg, assistiamo alla prima visione che ha László del simbolo per eccellenza degli USA, la Statua della Libertà: una visione per nulla quadrata ed esaltante, ma anzi stranamente (e sinistramente) rovesciata e distorta, quasi come se fosse un avvertimento, un campanello d’allarme, un sogno che potrebbe tramutarsi in un incubo, ma László ne è assolutamente incurante, e alla vista del Simbolo per eccellenza della grandeur americana si lascia andare ai festeggiamenti, consapevole che, dopo essere passato dai campi di concentramento, nulla può essere peggio…
Giunge poi a Philadelphia ospite a casa di suo cugino Attila Molnàr (Alessandro Nivola), che lavora come venditore di mobili, e che si è convertito al cattolicesimo, rifacendosi un identità da “perfetto americano”, eliminando anche il suo accento ungherese e cambiando il suo cognome in “Miller“, il tutto per sposare la sua attuale moglie, Audrey (Emma Laird). Attila offre a László un lavoro come impiegato nel suo studio, dove può dare sfogo alla sua creatività, mettendosi in mostra per le sue particolari opere brutaliste.
Un giorno ricevono un incarico importante da parte di Harry Lee Van Buren (Joe Alwyn), giovane rampollo della ricca famiglia di industriali Van Buren, che vuole fare una sorpresa al padre, chiedendo ad Attila e ai suoi uomini di ristrutturare da cima a fondo la libreria del capofamiglia. László prende personalmente in mano lo svolgimento dei lavori, e trasforma completamente quello spazio, facendo costruire delle particolari “librerie a scomparsa”, in modo da rendere il luogo più ordinato e meno claustrofobico.
Il problema è che il padrone di casa, il magnate Harrison Lee Van Buren (un sempre ottimo Guy Pearce), giunge a sorpresa nella tenuta, e non prende affatto bene la presenza di sconosciuti in casa sua, e neppure il totale cambiamento della libreria, cacciando a male parole gli architetti e gli operai: vista la brutale reazione del padre, il figlio si rifiuta di pagare il lavoro al team di László e Attila.
Per László le cose si mettono male: viene cacciato di casa dallo stesso Attila, che lo accusa del fallimento del lavoro e anche (falsamente) di averci provato con sua moglie (di fede cattolica, che sin dall’inizio mal sopportava la presenza di un ebreo come László nell’abitazione) e, tre anni dopo, finisce a lavorare come manovale, spalando carbone per mantenersi e diventando dipendente dall’eroina. Il “sogno americano” pare essersi tramutato in poco tempo in un “incubo”.
Pare, perché il magnate Harrison Van Buren riesce a rintracciare lo stesso László, scusandosi con lui per come lo aveva trattato anni prima e pagandolo per il lavoro svolto. Il motivo di questo “pentimento”? La libreria del magnate ha ricevuto grandi apprezzamenti dalle riviste del settore e quest’ultimo, facendo delle indagini personali, ha scoperto che László Tóth era un celebre architetto nel suo Paese, esponente della scuola artistica del Bauhaus, prima che i nazisti lo perseguitassero.
Harrison, dopo aver introdotto László all’alta società statunitense, tra affaristi e politici, gli commissiona un lavoro a suo dire “epocale”: la costruzione di un gigantesco centro ricreativo, intitolato alla memoria della madre, in cui poter svolgere attività ludiche, intellettuali e anche funzioni religiose, situato a pochi passa dalla sua villa. László accetta volentieri, ma questo progetto bigger than life lo porterà ben presto alla follia…
The Brutalist è molto di più che un’ennesima parabola sull’inganno del “Sogno Americano” (già vista e rivista): è un’opera che ragiona sul legame tra arte e profitto, tra cultura e mercato, sottolineando (una volta per tutte) una chiara incompatibilità tra le necessita espressive di un’artista e le logiche guidate unicamente dal successo personale, dal potere dei soldi e dall’arrivismo.
Dopotutto era tutto chiaro sin dall’incontro “chiarificatore” tra László e Van Buren, in cui quest’ultimo spende anni della sua vita unicamente per ricercare quell’architetto ebreo che tempo prima aveva maltrattato: il tutto unicamente perché quella libreria da lui inizialmente rigettata gli ha fatto ottenere la stima tra gli addetti ai lavori, dunque un prestigio maggiore di quello che già possedeva, e quel prestigio va consolidato, difeso e (se possibile) espanso, con il maestoso progetto che deciderà di commissionare a László stesso.
Van Buren non agisce affatto perché spinto dalla passione per l’arte architettonica, non è certo un mecenate di epoca rinascimentale, ma un capitalista nato e cresciuto nella terra per eccellenza del capitalismo, in cui ciò che conta è scalare la piramide del potere, accrescere il proprio status symbol e ottenere ancora più autorità nella sua classe sociale, a qualsiasi costo.
Dall’altra parte (quella dell’artista, non mosso dalle logiche del denaro), László questo progetto lo affronta come una questione di vita o di morte: quella costruzione è il suo personale esorcismo, la sua rielaborazione del Trauma (con la maiuscola, essendo il Trauma storico per definizione) vissuto con l’Olocausto (come si capirà meglio nella parte finale del film), l’opera in cui mettere davvero tutto sé stesso, in cui sacrificare ogni singolo aspetto della propria esistenza personale, anche a costo di impazzire.
Neanche l’arrivo, tanto desiderato, della moglie Erzsebet (Felicity Jones), ridotta in sedia a rotelle a causa dell’osteoporosi, e della figlia Zsòfia (Raffey Cassidy), diventata muta, riesce a migliorare la sua situazione: ormai László ha come priorità assoluta la costruzione di quel centro, e chiunque si metta in mezzo a lui e al suo obiettivo finale, viene maltrattato e respinto.
Il rapporto tra lui e Harrison è un rapporto tossico: il magnate difende apparentemente ogni scelta e modifica apportata dal suo stimato architetto al progetto, mostrando grande fiducia nelle sue capacità, ma al tempo stesso, per ridurre i costi esorbitanti, fa apportare delle modifiche ai suoi appaltatori che fanno infuriare lo stesso László, costretto a tagliare parte del suo compenso per poterle portare a termine: la differenza tra chi ragiona col cuore e chi col portafogli.
Inoltre il figlio del magnate, Harry, infastidisce continuamente Zsòfia, e László intima alla figlia di stare il più possibile alla larga da lui, mentre lo stesso Harry fa capire all’architetto che nel loro ambiente uno come lui è soltanto “tollerato”, e infatti al primo pretesto viene tranquillamente scaricato: Harrison gli dà la colpa “morale” assoluta di un incidente ferroviario, in cui vi erano trasportati dei materiali per l’edificio, licenziando in tronco lui e tutti gli operai. Ancora una volta, se si rischia di perdere denaro e potere, il capitalista abusa del suo potere, e scarica le sue responsabilità chi sta sotto di lui nella piramide sociale (salvo poi riprenderlo, una volta che il prestigio è salvo).
La scena chiave del film, che racconta e racchiude perfettamente il rapporto tra i due, l’Artista e il Padrone, è quella che si svolge a Carrara, in cui László e Harrison si sono recati per recuperare il celeberrimo marmo, essenziale per la costruzione dell’edificio: dopo una festa notturna, in cui l’architetto finisce per ubriacarsi e drogarsi, il tycoon abusa sessualmente di lui, riempiendolo anche di insulti xenofobi. Qui il magnate getta completamente la maschera, mostrandosi per ciò che è realmente, ovvero un razzista conservatore nei confronti di chiunque non sia un Wasp (“White Anglo-Saxon Protestant“) come lui: il ritratto più lucido del capitalismo USA.
Nel finale però l’Arte si prende forse una piccola rivincita nei confronti del Capitale: dopo essere stato accusato da Erzsebet, la moglie di László, di violenza sessuale nei confronti del marito, davanti a tutto il clan familiare e ad alcuni soci di affari, Van Buren sparisce misteriosamente. Non riescono a trovarlo e, seppur il film non lo chiarisca, è probabile che possa essersi suicidato, mentre nell’Epilogo, ambientato nel 1980 a Venezia (30 anni dopo gli eventi narrati), alle opere di László (ormai anziano) viene dedicata una retrospettiva, tra cui lo stesso centro a cui ha dedicato decenni della sua esistenza.
“Ciò che conta è la destinazione, non il viaggio“, è la battuta finale che chiude il film, ad opera di Zsòfia, l’ormai adulta figlia di László, le cui opere saranno destinate a rimanere nella Storia, a superare lo scorrere del Tempo, mentre il nome di Harrison Van Buren è solo questione di tempo prima che venga dimenticato.
The Brutalist ricorda, per grandeur produttiva e filmica, le opere più ambiziose dei cineasti emersi nella “New Hollywood“, capaci di raccontare grandi epopee individuali e collettive: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Cimino ecc…Tra i nuovi registi emersi negli ultimi 20 anni, l’unico a realizzare opere di simile portata, così radicali nella messa in scena e nella del racconto, è sicuramente Paul Thomas Anderson, e basti solo pensare a film come “Il petroliere” (“There will be blood”, 2007) oppure “The Master” (2012) per rendersi conto che il film di Corbet se non raggiunge quei livelli (ma questo lo dirà solo il tempo), ci va molto vicino.
Un film fuori dal tempo ma al tempo stesso fuori tempo massimo per logiche produttive e commerciali del cinema contemporaneo, The Brutalist è un film che sfida il grande pubblico, che non a caso (vedendo il passato da attore di Corbet), possiede una sensibilità artistica che è più vicina alle logiche del cinema d’autore europeo, che al cinema hollywoodiano degli ultimi decenni e che, pur guardando al passato, è comunque ben proiettato al presente (vedendo poi cosa sono oggi gli USA oggi…): esattamente come le opere di Toth, il film di Brady Corbet rimarrà nella Storia.