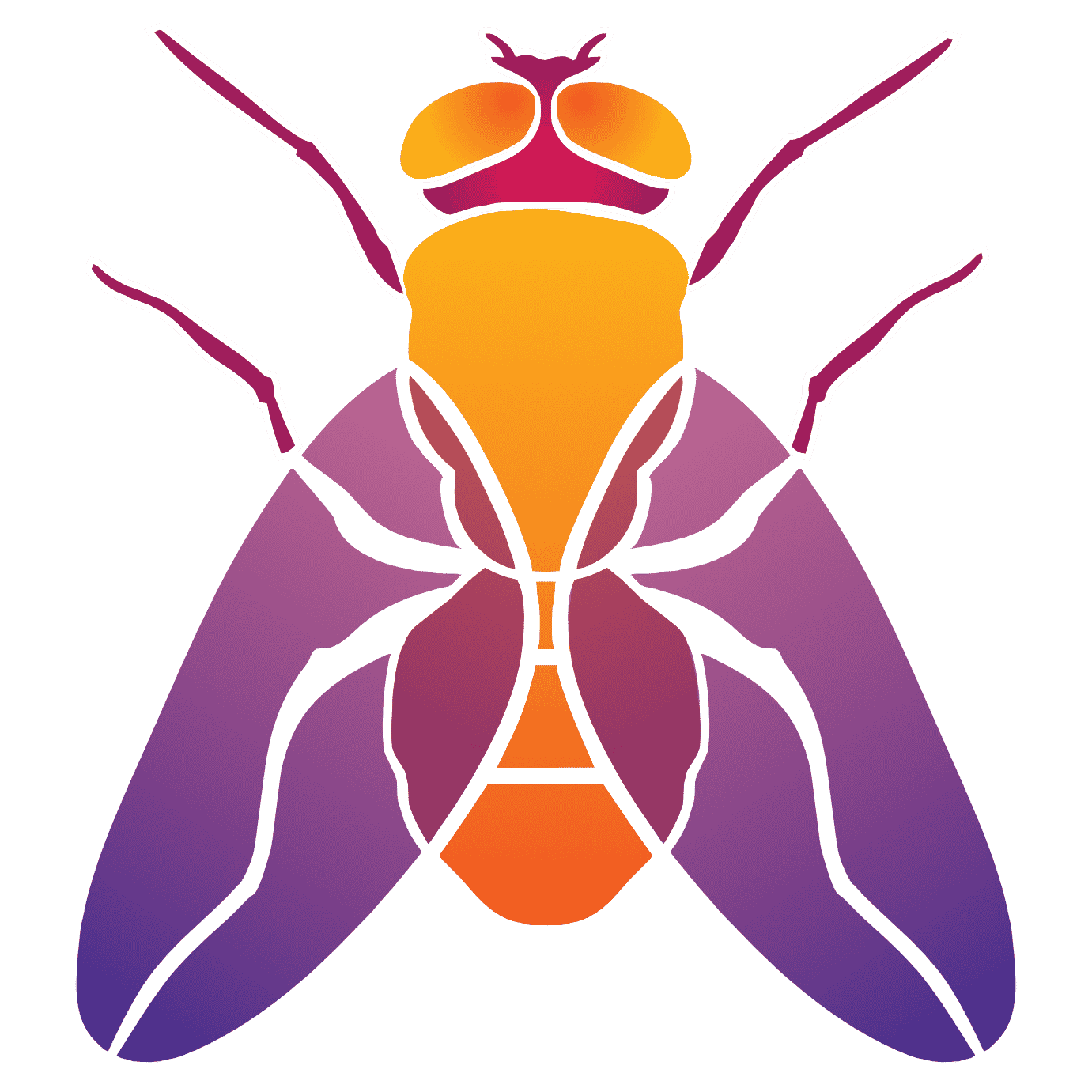“Justin Kemp, di professione giornalista e con un passato da alcolista, viene convocato dal tribunale di Savannah (Georgia) in qualità di giurato, durante un processo per l’omicidio di una donna, avvenuto un anno prima. L’uomo accetta, ma si rende ben presto conto che quel caso lo riguarda da vicino, mettendo in crisi tutte le certezze sulla sua vita passata e soprattutto futura…“.

Dopo quasi 70 anni di onorata carriera cinematografica, il 94enne Clint Eastwood si ritira ufficialmente dalle scene, regalandoci come ultima (grande) opera un legal drama solido, coinvolgente e ispirato, ovvero Giurato Numero 2.
Una carriera d’attore quella del vecchio Clint iniziata a metà degli anni 50, ma consacratasi (come tutti sanno) in Italia, grazie alla “trilogia del dollaro” del nostro Sergio Leone, mentre come regista il suo debutto risale al 1971 con il thriller “Brivido nella notte” (“Play Misty for Me“), che ha dato inizio ad un percorso durato più di 40 anni, portandolo a consacrarsi come dei massimi autori americani degli ultimi decenni (la sua fama dietro la macchina da presa è riuscita ad eguagliare quella attoriale).
In Giurato Numero 2, come detto, si parla della giustizia a stelle e strisce, un tema che Eastwood aveva già perfettamente affrontato in due sue recenti opere, “Sully” (2016) e soprattutto “Richard Jewell” (2019), entrambi tratte da fatti realmente accaduti, a differenza di Giurato Numero 2, storia originale (ma “verosimile”) scritta da Jonathan Abrams, al suo debutto come sceneggiatore per il cinema.
A differenza delle due precedenti pellicole, che trattavano di due persone innocenti (il pilota Sully e la guardia di sicurezza Richard Jewell) vittime di gravi errori giudiziari e della loro strenua battaglia legale per provare la loro innocenza, in Giurato Numero 2 il punto di vista è totalmente opposto, ovvero quello del colpevole del fatto.
Il protagonista della storia è Justin Kemp (ben interpretato da Nicholas Hoult) un giornalista con un passato da alcolista, e con una moglie prossima alla gravidanza: Justin viene convocato in qualità di giurato ad un processo per omicidio colposo, per dei fatti accaduti un anno prima, in cui un uomo avrebbe ucciso la sua fidanzata dopo una lite in un bar fuori città, investendola con la sua vettura.
Il problema è che Justin si rende ben presto conto che quell’uomo è innocente, perché quell’omicidio lo ha compiuto lui, seppur “involontariamente”: nel bar quel giorno (o meglio quella notte, visto che i fatto sono accaduti in orario notturno) c’era anche lui, tentato di ricominciare a bere, in un momento di debolezza umana (come tanti possono capitare nella vita).
Dopo essersi messo alla guida, in condizione metereologiche pessime (pioggia a dirotto), Justin urta qualcosa sotto la sua macchina: spaventato, esce dalla vettura ma non si accorge di nulla, pensando dunque di aver investito un cervo (che in quella zona passano di frequente) finito sotto il cavalcavia della strada, e si rimette in marcia come se nulla fosse. Un anno dopo però, si rende conto delle terribili conseguenze che quella sua tragica e incosciente azione ha generato, visto che alla sbarra del tribunale c’è un innocente che tutti, tra i suoi colleghi giurati, credono colpevole senza appello…
Justin, in preda ai sensi di colpa, pensa inizialmente di costituirsi, ma il suo avvocato lo avverte che a causa del suo passato da alcolista (e avendo preso da bere quella sera), rischia comunque il carcere a vita, malgrado l’involontarietà dell’omicidio: l’etica della giustizia in questo caso è francamente discutibile, ed infatti è una delle tematiche principali affrontate dalla pellicola, ma non solo…
Justin si trova infatti di fronte alla scelta più importante e dolorosa della sua vita: da un lato, il cercare di salvarsi la pelle lo farebbe vivere a vita con un rimorso insanabile, poiché questo significherebbe mettere in galera un innocente ma, dall’altra parte, il far scagionare l’imputato da tutte le accuse farebbe riaprire tutte le indagini (visto il clamore mediatico suscitato dal processo), e ciò significherebbe vivere gran parte della propria esistenza con la perenne ansia di essere scoperto e catturato…
Il dilemma morale in cui si trova Justin è di quelli apparentemente insormontabili: sacrificare tutta la propria vita (un matrimonio felice e un figlio che sta per nascere) per far trionfare la verità, oppure scappare come un codardo dalle proprie responsabilità, seppur come detto create da un atto “involontario”: “un uomo sfortunato vittima di terribili coincidenze“, si auto-definisce Justin in una scena del film, ma per la giustizia questo è un dettaglio che apparentemente non conta nulla…
Il falso colpevole dell’omicidio della donna, ovvero il suo ex-fidanzato, agli occhi di tutta la giuria, dell’opinione pubblica e ovviamente dell’avvocata dell’accusa (interpretata da Toni Collette), pare essere il chiaro ed evidente colpevole del fatto: ex-criminale con precedenti penali, con tanto di video girati quella sera nel bar in cui litiga furiosamente con la ragazza (che era ubriaca), e l’essere andato in macchina subito dopo averla lasciata andare, paiono essere prove più che definitive per una facile accusa…
Il bias cognitivo di cui quasi tutti sono “vittime” fa il resto: colpevoli di questi casi sono quasi sempre questa tipologia di uomo (maschio bianco etero con problemi di relazione con la propria ragazza), per di più con un passato criminoso che costituisce di per sé una decisiva aggravante: “quasi” però…
Justin decide alla fine di provare a tutti i costi a salvare quell’uomo, anche perché in fondo si somigliano (entrambi con un passato difficile alle spalle, e che stavano cercando di cambiare le loro vite per il meglio), e farà di tutto per far cambiare idea agli altri 11 giurati, ma chiaramente la sua pare essere sin dall’inizio una missione impossibile, dato che i suoi “colleghi” paiono intenzionati a condannarlo senza neppure esaminare ulteriormente il caso…
Esattamente come Henry Fonda in quel capolavoro de “La parola ai giurati” (1957), diretto da Sidney Lumet, (a cui Eastwood si ispira per le modalità di narrazione dei fatti), Justin sarà quel giurato (in questo caso il numero 2, mentre Fonda era il numero 8) che tenterà di lottare con ogni mezzo per far riaprire il caso contro un innocente, solo che le motivazioni sono ovviamente differenti, visto che allora era il bias cognitivo dettato dal razzismo degli altri giurati (il presunto colpevole era infatti un uomo di colore in un periodo di segregazione razziale in USA).
Eastwood riesce a costruire un legal drama di grande tensione emotiva, sfociando in diversi momenti nella costruzione filmica del thriller, pagando in positivo la scelta di raccontare la vicenda dal punto di vista del “colpevole”, creando nella spettatore un riuscitissimo senso di immedesimazione nei suoi confronti, che sfocia quasi nella pietà.
Azzeccata anche la scelta di raccontare il caso legale in uno stile alla “Rashomon” (1950) di Akira Kurosawa, ovvero tramite i flashback dei vari testimoni del processo, dove ognuno narra la sua versione dei fatti, in dei racconti che chiaramente non sono mai uguali, ma variano a seconda della percezione che ognuno di essi aveva in quella fatidica sera, facendosi anche influenzare dai soliti bias cognitivi (un vecchio ad esempio, pur non essendo del tutto sicuro di chi aveva visto, è comunque convinto che il colpevole sia il fidanzato della vittima, spinto unicamente dall'”emozione” di avere un ruolo così decisivo in un’indagine di questo tipo).
La verità dei fatti esiste e non è opinabile (l’omicidio della donna è un dato di fatto), ma l’interpretazione dei fatti e la ricerca della verità sono molto più difficili da raggiungere e ricercare di quello che sembra: è forse questo il centro del film di Eastwood, su quanto le apparenze siano davvero qualcosa di molto spesso ingannevole, anche quando ci paiono evidenti.
“La giustizia è verità in azione”, dice ad un certo punto del film il personaggio di Toni Collette, che interpreta come detto l’avvocata dell’accusa, ma per far sì che la verità venga a galla occorre non fermarsi mai neanche di fronte a ciò che ci pare sicuro: bisogna indagare, approfondire, lasciar da parte le emozioni e far prevalere il senso critico, specie se si parla di mandare in carcere a vita un innocente.
Ed è quello che fa proprio quest’ultima, che passa dall’essere convinta al 100% che l’ex fidanzato della ragazza sia il colpevole, al ritrovarsi sommersa dai dubbi e dalle incertezze una volta che inizia ad indagare al caso per conto proprio, arrivando anche a parlare faccia a faccia con il presunto colpevole.
Ed è anche quello che tenta di fare Justin con gli altri 11 membri della giuria convinti che l’imputato sia colpevole al 100%: alla fine riesce a far dubitare la metà di loro, mentre gli altri rimangono fermamente convinti della loro posizione iniziali, rifiutandosi di cambiare il loro giudizio: per loro quell’uomo è colpevole, non vogliono sentire ragioni, e rifiutano per partito preso ulteriori ipotesi di indagine.
Il vecchio, ma lucidissimo, Eastwood ci presenta un’impietosa analisi di tutte le contraddizioni all’interno del sistema giudiziario del suo Paese: i giurati vengono selezionati in maniera superficiale e senza neppure domande approfondite sul loro conto (si scopre nel corso del film che uno di loro era un poliziotto, e dunque da regolamento non gli sarebbe permesso partecipare…), mentre nei loro ragionamenti dimostrano di essere tutt’altro che equilibrati e super partes…
Una neutralità pura è dunque impossibile da ottenere, perché tutti quei giurati sono tutti e 12 uomini con i loro pregiudizi, le loro personali ideologie e ovviamente con i loro timori, influenzati dall’ambiente in cui sono cresciuti, in cui hanno maturato una loro coscienza personale sul mondo e sui suoi abitanti: nonostante dovrebbero ricorrere al senso critico, alla fine fanno prevalere i loro sentimenti.
Non ci sono buoni e cattivi in questo film, soltanto esseri umani con le loro debolezze, che si rapportano alla realtà dei fatti guidati dalle proprie convinzioni personali, cercando una spiegazione all’origine dei mali che minano e disturbano la loro quotidianità, pensando ogni volta di avere risolto il problema, che invece si ripresenta sotto nuove vesti nel corso del tempo.
Se si vuole giungere alla verità e alla comprensione dei fatti occorre, come già menzionato, non farsi influenzare dalle emozioni, per quanto difficile e complesso possa essere, ma utilizzare il più possibile la ragione e il pragmatismo, perché altrimenti non si riuscirà mai ad avere una benché minima idea di giustizia, rischiando di punire degli innocenti unicamente per delle errate percezioni personali.
Clint Eastwood dice dunque addio al mondo della settima con un’opera capace di intrattenere lo spettatore e al tempo stesso farlo riflettere non poco su alcuni dubbi esistenziali che da sempre circondano la nostra società: Chapeau (per l’ultima volta).